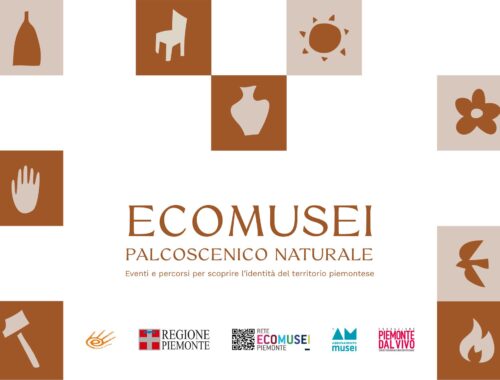Biodiversità e diversità linguistico-culturale
On n’habite pas un pays, on habite une langue
E. M. Cioran
Nell’ambito della Settimana del Paesaggio, l’Ecomuseo di Cascina Moglioni ha presentato, nella Sezione Paesaggio è diversità, una versione aggiornata del video intitolato P.I.U.M.A. (vedi nota 1) (GUARDA IL VIDEO) con il quale aveva partecipato al Premio Nazionale del Paesaggio. Il filmato, con una serie di immagini riferibili alle praterie e ai prati da pascolo presenti nell’area dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni – Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, vuole proporre una riflessione sull’importanza di saper rielaborare le buone pratiche del passato, alla luce delle recenti conoscenze scientifiche, per una gestione intelligente del paesaggio nella consapevolezza che diversità biologica della Terra (biodiversità) e diversità linguistico-culturale sono tra loro inseparabili e necessarie contro i più recenti processi di omologazione. Numerose ricerche hanno dimostrato il legame storico di questo binomio che, pur risultando oggi in crisi, è andato a lungo consolidandosi fin dalla comparsa dell’uomo sul Pianeta. Per millenni, le società umane si sono evolute con la natura, hanno imparato a conoscerla e a definirla attraverso le parole; si sono diversificate adattandosi al loro ambiente naturale e dando vita ad una biblioteca vivente di informazioni che l’industrializzazione dei secoli scorsi e la globalizzazione attuale hanno in buona parte depauperato. Anche se negli ultimi decenni alle comunità che ancora abitano in zone remote della Terra è stato finalmente riconosciuto un ruolo determinante per la conoscenza e la conservazione di piante, animali, ecosistemi, nella lotta contro la perdita di diversità, il percorso resta ancora impervio: nonostante gli sforzi, queste popolazioni, così come migliaia di specie vegetali e animali, vengono costantemente minacciate, insieme ai loro sistemi linguistici. Ed è in particolare sulle lingue, ritenute componente essenziale dell’identità, della diversità, del patrimonio vivente di una popolazione (vedi nota 2), che si sono attuati programmi internazionali specifici, finalizzati a tutelare le parlate minoritarie come ulteriore strumento per il mantenimento della vitalità ecologica del pianeta in considerazione del fatto che, numerosissimi idiomi, circa la metà dei 6000-7000 registrati a inizio 2000, risultavano allora a rischio di estinzione e con essi gli habitat nei quali i rispettivi parlanti vivevano. Alcuni studi hanno evidenziato inoltre come i processi di diversificazione linguistica sembrino seguire regole analoghe a quelle applicabili in campo naturalistico (vedi nota 3). Ma più semplicemente le lingue assumono in ambito ambientale un ruolo importante perché sottendono una fitta rete fatta di memoria, saperi, valori che una volta persi, lo saranno per sempre ed è proprio al fine di sensibilizzare i più giovani che l’Ecomuseo di Cascina Moglioni si è occupato di queste tematiche, anni fa, con il progetto Biodiversity, Tutte le lingue del mondo – Il dialetto di Marcarolo, al quale hanno partecipato tre licei linguistici della zona. E, in effetti, nel panorama Italiano i numerosi dialetti ancora parlati assumono una funzione analoga a quei sistemi linguistici ‘esotici’ sopra citati. Emblematico, il noto passo di Rigoni Stern, tratto da Sentieri sotto la neve, nel quale egli elenca i modi con cui gli abitanti dell’Altipiano di Asiago chiamavano la neve (nota 4), uno straordinario repertorio, spia di una minuziosa osservazione del mondo naturale e, al contempo, testimonianza storica del rapido cambiamento climatico a cui stiamo assistendo.
A proposito del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, utili notizie sul rapporto lingua e gestione degli ambienti naturali, delle praterie e dei prati da pascolo, da cui siamo partiti, emergono nella pubblicazione LE PAROLE, GLI STRUMENTI, LA MEMORIA di Claudia Alessandri, un’indagine etno-linguistica che, attraverso lo studio del dialetto e degli usi locali, ci restituisce preziose informazioni storiche e naturalistiche di un luogo, Capanne di Marcarolo, e dei suoi abitanti. In particolare, per tornare agli habitat del filmato P.I.U.M.A., alcuni paragrafi del libro sono appunto dedicati al pascolo e alla fienagione, alla scansione annuale dei lavori, agli attrezzi utilizzati, nomi e pratiche negli anni quasi dimenticati, ma fondamentali per garantire la presenza di specie legate all’attività antropica e il mantenimento di ambienti ricchi in biodiversità.

DETTAGLI DEL LIBRO
TITOLO: LE PAROLE, GLI STRUMENTI, LA MEMORIA – Indagine etnolinguistica nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo
AUTORE: Claudia Alessandri
LUOGO E ANNO DI PUBBLICAZIONE: Alessandria, 2007
CASA EDITRICE/TIPOGRAFIA: Edizioni dell’Orso s.r.l.
DIMENSIONI: 23,5×17
FORMATO: Brossura – Testo con fotografie e disegni
NUMERO DI PAGINE: 182
PREZZO: € 20
BREVE DESCRIZIONE: L’indagine di cui si dà conto, effettuata nel corso dell’autunno del 2005 e dell’estate successiva, muove dall’esperienza di famosi specialisti come Hugo Plomteux, che sottolineava l’importanza di mettere in relazione lo studio dei dialetti con il mondo che essi stessi rappresentavano e descrivevano. Una ricerca pertanto che, oltre a fornire indicazioni sulla fonetica, sulla morfosintassi e sui termini dialettali ancora in uso (raccolti in modo efficace in un glossario presente nel volume), vuole raccontare la realtà, non solo linguistica, di Capanne di Marcarolo, un piccolo centro che, per diverse ragioni storico-geografiche, ha conservato nel tempo caratteristiche estremamente originali. Suddivisa in quattro parti (l’ambiente naturale, la vita di relazione, il lavoro umano, la vita dell’uomo) e facilmente fruibile anche dai non addetti ai lavori, la pubblicazione riporta con precisione e, al tempo stesso, con grande partecipazione da parte dell’autrice, uno spaccato della vita di Capanne e dei suoi abitanti, sospesi tra modernità e pratiche antiche. I dati presentati sono stati raccolti attraverso differenti modalità: compilazione di questionari, registrazioni, osservazioni, privilegiando la testimonianza diretta dei parlanti. Per la realizzazione dello studio sono stati individuati 13 abitanti delle cascine di Capanne di diversa età al fine di fornire una panoramica il più possibile completa. Tra i risultati più significativi, insieme ad una certa variabilità all’interno del gruppo dei parlanti – con una contaminazione maggiore delle parlate dei paesi limitrofi per i soggetti più giovani – emerge, come era prevedibile, uno stretto legame con il fonetismo genovese e ligure occidentale; persistono, tuttavia, alcuni tratti arcaici che hanno reso il dialetto di Capanne, forse per un antico isolamento, una lingua conservativa.
Nell’ambito dello studio del dialetto locale, minacciato dall’uso esclusivo dell’italiano, da un numero sempre più esiguo di abitanti autoctoni e da una modernità che a grande velocità si allontana dalle antiche pratiche raccontate da quella lingua, ‘LE PAROLE, GLI STRUMENTI, LA MEMORIA’, rappresenta certamente un importante punto di arrivo, una dimostrazione diretta di come sistemi linguistici e memoria storica di una civiltà siano strettamente collegati.
Note
1 – Canale Youtube ufficiale dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese https://www.youtube.com/channel/UCDI3N66nrlmdWm6gjp37G-A/featured
2 – Atlas UNESCO des langues en danger dans le monde dal Sito UNESCO dedicato alle lingue in pericolo http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php
3 – Diversi ricercatori sostengono che le lingue, seguendo quanto accade per le specie vegetali e animali (Regola di Rapoport), tendono ad aumentare in modo significativo di numero procedendo dai Poli verso l’Equatore; inoltre, secondo Marc Pagel – Università di Reading – la diversificazione linguistica, legata solo in parte all’isolamento geografico, sarebbe dettata altresì dall’istinto di sopravvivenza di una specifica comunità, spesso in lotta contro le altre per la difesa delle risorse e del territorio: attraverso un processo paragonabile alla specializzazione biologica, la nascita di una nuova lingua permetterebbe ai membri del gruppo di non farsi comprendere all’esterno e di potersi difendere in modo più efficace da eventuali nemici.
4 – Ho tante nevi nella memoria: nevi di slavine, nevi di alte quote, nevi di montagne albanesi, di steppe russe, di lande polacche. Ma non di queste intendo parlare, dirò di come le nevi un tempo venivano indicate dalle mie parti: nevi dai più nomi, nevi d’antan, non considerate nei bollettini della stazioni meteorologiche. BRÜSKALAN, la prima neve dell’anno, dunque in autunno, quella vera: lo si sentiva nell’aria l’odore della prima neve, un odore pulito, leggero, più buono e grato di quello della nebbia. È la neve che copre i campi, li infarina, che avvolge ogni cosa di un velo bianco. SNEEA, neve abbondante e leggera giù dal molino del cielo: le voci si affievoliscono, il mondo diventa ovattato. È neve da sci e slittini, da caldo del focolare e della stua. HAAPAR, neve di fine inverno, che si scioglie al sole e lascia intravedere il terreno sottostante. Le prime allodole cantano all’imminente primavera. HAARNUST, neve vecchia che verso primavera, nelle ore calde, il sole ammorbidisce in superficie e che poi il freddo della notte indurisce. Neve per escursioni fuori pista a piedi o con gli sci, ma solo fino a metà mattina, fino a che sopporta il peso senza cedere: vi si cammina come sospesi. SWALBALASNEEA, la neve della rondine, la neve di marzo che è sempre puntuale nei secoli, soffice o bagnata, larga o simile a tormenta, volubile come il clima di marzo, neve che è l’ultima resistenza dell’inverno. KUKSNEEA, la neve di aprile: sui prati che incominciano a rinverdire e dove sono fioriti i crochi non si ferma molto perché ancora prima del sole la terra in amore la fa sciogliere. Neve effimera, neve di fine stagione. BÀCHTALASNEEA, la neve della quaglia, neve di maggio, non frequente, ma neppure rara: la temperatura cala bruscamente, una grossa nuvola si avvicina e per poche ore butta la neve sui tarassachi e sui miosotidi, allarmando i caprioli, spaventando gli uccelli e uccidendo le api avventuratesi nei prati. KUASNEEA, la neve delle vacche, la rara neve d’estate, che fa scendere urlanti dai pascoli le vacche affamate. (Rigoni Stern, Sentieri sotto la neve)
GLI ECOMUSEI SONO PAESAGGIO
Nella settimana dal 21 al 25 giugno è iniziata l’iniziativa GLI ECOMUSEI SONO PAESAGGIO con la Settimana del Paesaggio, iniziativa promossa dalla Rete degli Ecomusei Italiani in collaborazione con la Rete Ecomusei Piemonte.
La rassegna ricca e articolata, proseguirà con una serie di eventi a cura dalle reti regionali dal titolo Il paesaggio visto dagli ecomusei dal 28 giugno al 30 settembre e si concluderà in autunno con tre importanti tavole rotonde dedicate al ruolo degli ecomusei rispetto alla crisi climatica, alla Convenzione Europea del Paesaggio ed al Sistema Museale Nazionale.
La Settimana del Paesaggio ha visto la partecipazione di più di trenta ecomusei e soggetti diversi che operano per la cura del paesaggio. Si è fatta una riflessione sulla necessità di mettere a punto nuovi modelli di sviluppo locale basati su pratiche di sostenibilità ambientale e paesaggistica in grado di promuovere nuovi modelli di economie locali auto-sostenibili.
Sette tavoli tematici alla presenza di personalità del modo della ricerca, delle istituzioni e del terzo settore, hanno cercato di approfondire le diverse declinazioni che può assumere il paesaggio per le comunità che lo hanno prodotto e di dialogare sugli effetti possibili dettati dalle condizioni post-pandemiche, guardando con particolare attenzione all’attuazione del PNRR.
Nell’ambito dei singoli tavoli tematici, sono stati presentati alcuni dei 50 video raccolti come testimonianza delle ‘’buone pratiche’ sul paesaggio sviluppate nel nostro Paese dalle Alpi al Mediterraneo, che evidenziano il ruolo sempre più attivo delle comunità nelle decisioni degli enti locali e territoriali, rispetto al tema delle filiere corte, dell’economia circolare, della difesa delle diversità, della resilienza all’abbandono delle campagne, della partecipazione attiva, della ricerca del benessere basata su azioni concrete di uno sviluppo locale sostenibile.
Una settimana quindi per tornare a parlare di paesaggio come bene comune e per tracciare un primo resoconto dei risultati a 50 anni dalla nascita del concetto di ecomuseo.
I Tavoli tematici della Settimana del Paesaggio sono disponibili sulla pagina Facebook degli Ecomusei Italiani: https://www.facebook.com/Ecomuseiitaliani
SCARICA IL PROGRAMMA DI “GLI ECOMUSEI SONO PAESAGGIO”
Potrebbe anche piacerti
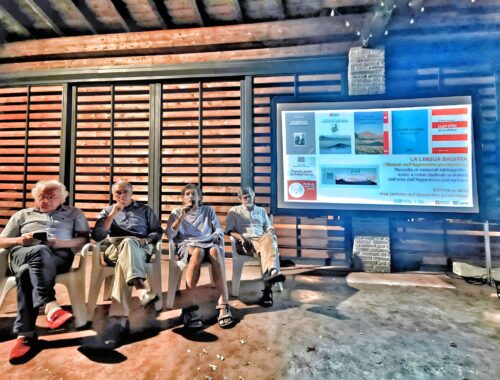
La lingua salvata. I dialetti dell’Appennino piemontese
31 Agosto 2023
Ecomuseo di Cascina Moglioni – Orari di apertura 2025
29 Marzo 2023